Tomba a enchytrismòs
Nella necropoli di Sulky sono state rinvenute un buon numero di sepolture a enchytrismòs, tipologia tombale che venne utilizzata a partire già dalla preistoria, quando talora si ricorreva al seppellimento all’interno di grandi ziri (fig. 1), mentre in epoca punica, romana e paleocristiana, vennero utilizzate le anfore, soprattutto per l’inumazione dei bambini.

L’anfora, quando utilizzata per gli infanti deceduti in tenera età, veniva tagliata di lungo per permettere l’inserimento del corpo; la parte tagliata era poi riaccostata e l’anfora deposta all’interno di una fossa (fig. 2).

In caso di sepolture di adulti, essendo le anfore piccole per contenerne il corpo, ne erano utilizzate due, le quali, una volta tagliate dalla parte della spalla nel senso trasversale e poi di nuovo anche di lungo per permettere l’inserimento del corpo, venivano accostate in modo da formare un unico contenitore per la salma (fig. 3).

Per quanto riguarda l’Età Punica, la sepoltura a enchytrismòs compare durante l’ultima parte del VI sec. a.C. e resiste sino agli inizi del IV sec. a.C. Essa era realizzata con grandi anfore commerciali e vi erano inumati i bambini che, tra l’altro, venivano collocati in un’area ad essi dedicata all’interno della necropoli.
Durante l’Età Romana Imperiale, le anfore maggiormente utilizzate per l’inumazione dei defunti erano la Tripolitana, l’Africana I e l’Africana II, che, nella loro destinazione d’uso originale, venivano impiegate per trasportare olio e altri prodotti, tra i quali una salsa di pesce di cui i Romani andavano particolarmente ghiotti, il garum. Esse ci attestano il rapporto della città di Sulky con l’Africa (fig. 4).


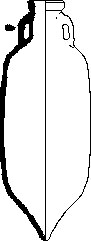

Pochi casi di sepolture di questa tipologia conservano il corredo d’accompagnamento. Questo è il caso della tomba 146 della necropoli di Sulky, in cui esso era stato deposto in parte all’interno ed in parte all’esterno dell’enchytrismòs.
Lo stato di conservazione delle anfore è spesso compromesso, per cui non sempre è facile individuarne il tipo, ma forniscono in ogni caso delle indicazioni generali sulla cronologia che si colloca tra la metà del II e il IV sec. d.C.
L’enchytrismòs per la sepoltura degli infanti prosegue in età paleocristiana, epoca durante la quale le anfore venivano spesso collocate nei loculi all’interno delle catacombe.
Bibliografia
- P. BARTOLONI, I Fenici e i Cartaginesi in Sardegna, Sassari 2009.
- V.CAMINNECI, Enchytrismòs. Seppellire in anfora nell’antica Agrigento, in V. CAMINNECI (a cura di) Parce Sepulto: il rito e la morte tra passato e presente, Agrigento 2012, pp. 111-132.
- E. CRUCCAS, Aspetti culturali della Nurra di età storica. Il caso delle cosiddette sepolture a enchytrismòs in E. CICU, A. GAVINI, M. SECHI, (a cura di), Alta formazione e ricerca in Sardegna. Atti del Convegno di Studi “Giovani Ricercatori”(Sassari, 16 dicembre 2011), Raleigh 2014, pp. 65-77.
- G. MAETZKE, Florinas (Sassari). Necropoli a enkytrismòs in località Cantaru Ena = Notizie degli Scavi di Antichità 1964, pp. 280-314.
- C. TRONCHETTI, S. Antioco, Sassari 1989.
- C. TRONCHETTI, La necropoli romana di Sulci. Scavi 1978: relazione preliminare = Quaderni della Soprintendenza Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano, Cagliari 1990, pp. 173-192.
- C. VISMARA, Un particolare tipo di sepoltura della Sardegna Romana: le tombe a enchytrismòs in Le sepolture in Sardegna dal IV al VII secolo. IV Convegno sull’archeologia tardoromana e altomedievale (Cuglieri, 27-28 giugno 1987), Oristano 1990, pp. 33-35.

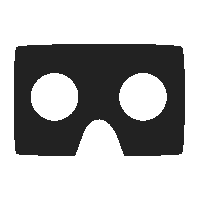 VR
VR